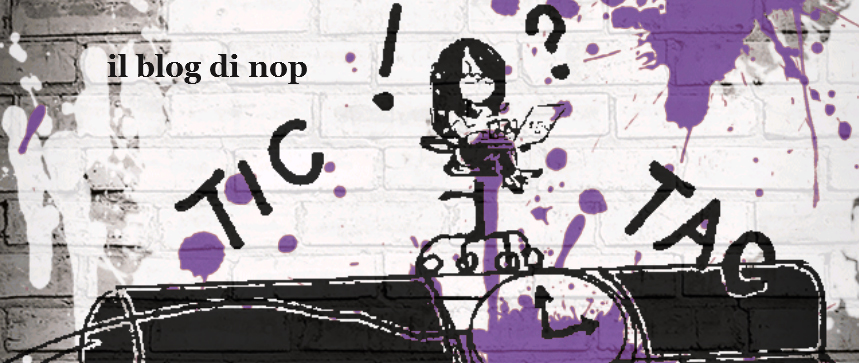Zehra Doğan, è un'artista curda, giornalista e femminsita, rinchiusa nelle carceri turche con l’accusa di propaganda terrorista per aver mostrato la violenza dell’esercito di Erdogan con una sua opera. Si trattava di un acquarello postato su Twitter tratto da una fotografia scattata da un soldato turco. Questo disegno digitale mostrava la città di Nusaybin distrutta dall’esercito nazionale nel giugno 2016 con le bandiere issate e trionfanti, e i blindati trasformati in scorpioni.
mercoledì 8 gennaio 2020
martedì 7 gennaio 2020
John Baldessari il "gigante gentile" dell'arte concettuale
Capita che alcuni artisti, a un certo punto della vita, si guardino indietro e si accorgano che tutto quello fatto fino ad allora non li rappresenta più. Decidono così di cambiare direzione rinnegando la propria formazione e produzione. Successe anche all'americano John Baldessari: inorridito davanti ai suoi dipinti giovanili decise di disfarsene in maniera eclatante.
Era il 1970 e lo fece in maniera artistica con una performance «The Cremation Project» destinata a scrivere un nuovo capitolo della storia dell' arte. Andò all' obitorio "Cypress View Mortuary" e fece cremare tutti i quadri in suo possesso. La cenere dei dipinti bruciati venne poi utilizzata come ingrediente per impastare alcune gallette, cotte e riposte in un barattolo, come in una sorta di urna cineraria. Per Baldessari la nuova opera d'arte consisteva nei Corpus Wafers, gli indigesti biscotti di quadro. Poi realizzò una targa metallica con inciso il suo nome e le date del debutto da pittore e dell' abbandono dell' arte tradizionale: «John Anthony Baldessari May 1953 March 1966». Così facendo, da una parte, da buon erede di Marcel Duchamp, Baldessari fece trionfare l'idea sulla forma, dall'altra impiegando i metodi distruttivi di Gustav Metzger e Jean Tinguely (nel suo caso un forno crematorio) mise in relazione la performance all'idea della morte e alla rinascita. «The Cremation Project» fu esposto al MoMA di New York nella mostra "Information".
Era il 1970 e lo fece in maniera artistica con una performance «The Cremation Project» destinata a scrivere un nuovo capitolo della storia dell' arte. Andò all' obitorio "Cypress View Mortuary" e fece cremare tutti i quadri in suo possesso. La cenere dei dipinti bruciati venne poi utilizzata come ingrediente per impastare alcune gallette, cotte e riposte in un barattolo, come in una sorta di urna cineraria. Per Baldessari la nuova opera d'arte consisteva nei Corpus Wafers, gli indigesti biscotti di quadro. Poi realizzò una targa metallica con inciso il suo nome e le date del debutto da pittore e dell' abbandono dell' arte tradizionale: «John Anthony Baldessari May 1953 March 1966». Così facendo, da una parte, da buon erede di Marcel Duchamp, Baldessari fece trionfare l'idea sulla forma, dall'altra impiegando i metodi distruttivi di Gustav Metzger e Jean Tinguely (nel suo caso un forno crematorio) mise in relazione la performance all'idea della morte e alla rinascita. «The Cremation Project» fu esposto al MoMA di New York nella mostra "Information".
martedì 10 dicembre 2019
Roska Óskarsdóttir, arte e militanza per la verità sulla Strage di Stato
Roska
Óskarsdóttir appartiene alla generazione di artisti radicali che hanno
voluto distruggere i confini tra arte e vita, che hanno combattuto contro lo
snobismo artistico della borghesia, la compiacenza politica delle masse e la
macchina dei professionisti della politica. Roska è stata pittrice, fotografa,
regista cinematografica ma soprattutto una sovversiva; il tema costante della
sua vita è stato "ribellione continua nel vivere la poesia e la
politica", come scrisse in un articolo del 1978 dedicato al surrealismo.
Insieme all'attore Manrico Pavolettoni, che in seguito
sarebbe divenuto suo marito, si impegnò per dimostrare l’innocenza
degli anarchici sotto processo per la strage di Piazza Fontana e per le bombe
di Roma. In particolare si misero alla ricerca di Udo Lemke, un giovane tedesco che la mattina del 13 dicembre 1969 si presentò in caserma dichiarando di aver
visto gli attentatori in azione all'Altare della Patria e di averli
riconosciuti. La storia di Lemke, che racconto nel mio libro "Le bombe di Roma", edito da
Castelvecchi, ha dell’incredibile.
Udo è un
personaggio marginale ma se si analizza il suo comportamento ci imbattiamo in
tante e tali stranezze che sembrano pianificate a tavolino: è un personaggio
che spunta fuori dal nulla, riesce a spostarsi con grande facilità per trovarsi
in situazioni che meriterebbero di essere chiarite; sparisce, riappare, parla e
poi ritratta, passa per pazzo ma dice cose che alla fine la Cassazione ha
dovuto in qualche modo ammettere. Il giorno dopo gli attentati aveva già
indicato la pista nera, già aveva parlato dei rapporti tra la mafia e l'estrema
destra, già aveva parlato di quel piano eversivo che verrà rivelato solo mesi
dopo. Il giorno dopo le bombe aveva già scagionato gli anarchici.
sabato 7 dicembre 2019
Emilio Vedova, la rabbia e la passione del pittore partigiano
Passione e rabbia fuse insieme dal colore. Pennellate grasse e nervose che allagano quadri immensi. Gesti titanici e ciechi che travolgono tutto. Foga, impeto e furore che smontano e rimontano strutture. È l'arte di Emilio Vedova, l'artista che nel Novecento più di tutti incarna l'uomo in rivolta. «La sua pittura è un' appassionata lotta contro l'avversario dietro la tela che nel più accanito contrasto del sì e del no, del bene e del male, del bianco e del nero, dovrà essere costretto a pronunciarsi», sostiene Werner Haftmann. «La tela, come una membrana nel mezzo della disputa registra il corso della contesa».
La sua biografia parla da sola. Negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale, Vedova fece parte, a Milano, del gruppo di "Corrente", nella cui galleria presentò una delle sue prime "personali". Dopo l'8 settembre 1943 partecipò alla Guerra di liberazione nelle file della Resistenza romana. Militò poi, col nome di battaglia di "Barabba" (scelto per la folta barba che ne avrebbe incorniciato il volto per tutta la vita), in una formazione partigiana molto attiva sull'altipiano bellunese. Nel corso di un rastrellamento "Barabba" fu ferito, ma riuscì, fortunosamente ad evitare di essere catturato dai nazifascisti.
La sua biografia parla da sola. Negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale, Vedova fece parte, a Milano, del gruppo di "Corrente", nella cui galleria presentò una delle sue prime "personali". Dopo l'8 settembre 1943 partecipò alla Guerra di liberazione nelle file della Resistenza romana. Militò poi, col nome di battaglia di "Barabba" (scelto per la folta barba che ne avrebbe incorniciato il volto per tutta la vita), in una formazione partigiana molto attiva sull'altipiano bellunese. Nel corso di un rastrellamento "Barabba" fu ferito, ma riuscì, fortunosamente ad evitare di essere catturato dai nazifascisti.
venerdì 22 novembre 2019
Divisionismo, quando la pittura diventò strumento di militanza politica
 |
| Emilio Longoni, L'oratore dello sciopero |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)