Roska
Óskarsdóttir appartiene alla generazione di artisti radicali che hanno
voluto distruggere i confini tra arte e vita, che hanno combattuto contro lo
snobismo artistico della borghesia, la compiacenza politica delle masse e la
macchina dei professionisti della politica. Roska è stata pittrice, fotografa,
regista cinematografica ma soprattutto una sovversiva; il tema costante della
sua vita è stato "ribellione continua nel vivere la poesia e la
politica", come scrisse in un articolo del 1978 dedicato al surrealismo.
Insieme all'attore Manrico Pavolettoni, che in seguito
sarebbe divenuto suo marito, si impegnò per dimostrare l’innocenza
degli anarchici sotto processo per la strage di Piazza Fontana e per le bombe
di Roma. In particolare si misero alla ricerca di Udo Lemke, un giovane tedesco che la mattina del 13 dicembre 1969 si presentò in caserma dichiarando di aver
visto gli attentatori in azione all'Altare della Patria e di averli
riconosciuti. La storia di Lemke, che racconto nel mio libro "Le bombe di Roma", edito da
Castelvecchi, ha dell’incredibile.
Udo è un
personaggio marginale ma se si analizza il suo comportamento ci imbattiamo in
tante e tali stranezze che sembrano pianificate a tavolino: è un personaggio
che spunta fuori dal nulla, riesce a spostarsi con grande facilità per trovarsi
in situazioni che meriterebbero di essere chiarite; sparisce, riappare, parla e
poi ritratta, passa per pazzo ma dice cose che alla fine la Cassazione ha
dovuto in qualche modo ammettere. Il giorno dopo gli attentati aveva già
indicato la pista nera, già aveva parlato dei rapporti tra la mafia e l'estrema
destra, già aveva parlato di quel piano eversivo che verrà rivelato solo mesi
dopo. Il giorno dopo le bombe aveva già scagionato gli anarchici.
È per
questo Roska e Manrico che si misero sulle sue tracce.
Volevano farlo testimoniare al processo sulle bombe del 12 dicembre. Attraverso
varie peripezie e strani incidenti riuscirono a portarlo a Milano, a farlo
interrogare e testimoniare, ma non fu sufficiente. Udo Lemke nell'agosto 1972
venne condannato per calunnia e rispedito in Germania dove si sono perse le sue
tracce.
Tornando a Roska, il suo vero nome era Ragnhildur Oskardottir ed era nata nel 1940 a
Reykjavik. Hjalmar Sveinsson, nella biografia a lei dedicata, racconta
che Roska, dopo aver lasciato la scuola secondaria, lavorò nella prima galleria
d'arte islandese privata poi continuò i suoi studi presso l'Icelandic College
of Art and Craft. Andò a Praga per un anno, ne trascorse un altro a Parigi,
poi si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Roma.
In occasione della sua
prima personale a Reykjeavik nel 1967, presso la galleria Casa Nova, presentò 55
dipinti e disegni, in gran parte in stile espressionistico figurativo, ma in
alcuni era già evidente l'ironia della pop art. La mostra fu pubblicizzata come
"un'introduzione artistica ad opera del Sum", un gruppo di giovani
artisti d'avanguardia che in seguito avrebbero avuto un grande impatto
sull'arte islandese. Roska fu invitata a unirsi al gruppo e a quell'epoca partecipò
a una esposizione all'aperto dove presentò una lavatrice trasformata in una
rampa di lancio missilistico. Questa fu probabilmente la prima opera d'arte
femminista in Islanda.

 A partire dal 1967
i suoi lavori divennero più politici e scoprì un mezzo in cui i giovani artisti
radicali riponevano grandi speranze: il cinema. Il primo film in cui recitò,
girato a Roma nel 1967, era "L'uomo della folla", basato sul racconto
omonimo di Edgar Allan Poe. Il regista era Oddo Bracci e il cameraman un giovane
americano di nome Tony Lurasky figlio di un dirigente della Paramount Picture.
Il protagonista maschile era l'islandese Hreinn Fridfinsson che all'epoca
viveva in via Giulia, uno dei fondatori del Sum. Il film fu proiettato due anni
dopo a una mostra del Sum ma tutte le copie sono andate perdute. Nel 1969 Roska
ha avuto anche a che fare con due film che Jean Luc Godard girò in Italia:
"La lutee ouvière en Italie" e "Vento dell'Ovest". Godard
all'epoca girava documentari politici e aveva fondato un gruppo, formato da
studenti e giovani filmmakers, che si identificava con il cineasta russo Dziga
Vertov. Presto all'interno del gruppo si manifestarono contrasti tra i maoisti
e gli anarchici. Godard si considerava un maoista, ma Roska e i suoi compagni si
vedevano come anarchici e infine produssero un loro film, intitolato
"L'impossibilità di recitare Elettra oggi". Il film racconta la
storia di alcuni giovani che intendono mettere in scena l'Elettra di Sofocle,
ma giungono alla conclusione che è impossibile, che l'unica vera arte sta nel
dialogo tra le persone che si impegnano nella battaglia dei lavoratori e si
ribellano contro l'autorità. L'ispirazione per il film veniva da una serie di
evanti che ebbero luogo nel 1968 nel paese di Fabbrico, presso Modena, dove lavoratori e studenti occuparono un cinema e una casa della cultura. La
stessa Roska partecipò agli eventi di Fabbrico, che la influenzarono
profondamente come i suoi diari dimostrano chiaramente.
A partire dal 1967
i suoi lavori divennero più politici e scoprì un mezzo in cui i giovani artisti
radicali riponevano grandi speranze: il cinema. Il primo film in cui recitò,
girato a Roma nel 1967, era "L'uomo della folla", basato sul racconto
omonimo di Edgar Allan Poe. Il regista era Oddo Bracci e il cameraman un giovane
americano di nome Tony Lurasky figlio di un dirigente della Paramount Picture.
Il protagonista maschile era l'islandese Hreinn Fridfinsson che all'epoca
viveva in via Giulia, uno dei fondatori del Sum. Il film fu proiettato due anni
dopo a una mostra del Sum ma tutte le copie sono andate perdute. Nel 1969 Roska
ha avuto anche a che fare con due film che Jean Luc Godard girò in Italia:
"La lutee ouvière en Italie" e "Vento dell'Ovest". Godard
all'epoca girava documentari politici e aveva fondato un gruppo, formato da
studenti e giovani filmmakers, che si identificava con il cineasta russo Dziga
Vertov. Presto all'interno del gruppo si manifestarono contrasti tra i maoisti
e gli anarchici. Godard si considerava un maoista, ma Roska e i suoi compagni si
vedevano come anarchici e infine produssero un loro film, intitolato
"L'impossibilità di recitare Elettra oggi". Il film racconta la
storia di alcuni giovani che intendono mettere in scena l'Elettra di Sofocle,
ma giungono alla conclusione che è impossibile, che l'unica vera arte sta nel
dialogo tra le persone che si impegnano nella battaglia dei lavoratori e si
ribellano contro l'autorità. L'ispirazione per il film veniva da una serie di
evanti che ebbero luogo nel 1968 nel paese di Fabbrico, presso Modena, dove lavoratori e studenti occuparono un cinema e una casa della cultura. La
stessa Roska partecipò agli eventi di Fabbrico, che la influenzarono
profondamente come i suoi diari dimostrano chiaramente.Nel novembre dello stesso anno fu responsabile di due spettacoli politici in autentico spirito situazionista: movimentò un festival in onore del premio Nobel islandese Haldor Laxness, poi salì sul palco agitando una bandiera nord-vietnamita mentre la sua amica Birna Thordardottir pronunciava un discorso contro il coinvolgimento militare americano in Vietnam con l'appoggio dato dall'Islanda e denunciando il fatto che Halldor Laxness sarebbe dovuto diventare l'amico di questa stessa borghesia che prima odiava. Il giorno seguente, accompagnata da un drappello di ragazzi islandesi, penetrò nella base aerea della marina americana di Keflavik, entrò nello studio televisivo e interruppe le trasmissioni per una buona mezz'ora spruzzando vernice rossa sulle lenti delle telecamere e poi dipingendo le parole "Viva Cuba!" e "Brain Wshing Centre" sulle pareti dello studio. Le trasmissioni tv della base americana erano ampiamente trasmesse in Islanda e venivano considerate una minaccia all'indipendenza culturale del paese sia dalla sinistra che dai militanti per i diritti civili.
Dal 12 dicembre 1969, pur partecipando a numerose collettive in Italia, Islanda e Spagna, spese gran parte delle sue energie nelle battaglie politiche, nella controinformazione anche disegnando manifesti, illustrazioni per giornali e riviste, come quelli per Lotta Continua.
Dal 1974 al 1976 lei e Manrico realizzarono otto documentari sull'Islanda per la Rai, ma la televisione islandese si rifiutò di mandarli in onda.
Nel '77 scrisse lo script del film "The Ballad of Olafur Liljuros", lungo 35 minuti, basato su un racconto popolare islandese.
Scrisse inoltre il lungometraggio "Soley" che uscì nel 1982 anch'esso ispirato a motivi del folklore islandese. Entrambi, nonostante i motivi etnici tratti dalla società contadina islandese, possono essere visti come allegorie della lotta per la sopravvivenza di gruppi oppressi. Il nemico, tuttavia non è più il capitalismo come potere mondiale, ma piuttosto le catene della mente umana che impediscono alla gente di realizzare i propri sogni.
Durante gli anni Ottanta sembrò che Roska si fosse ritirata per sempre. C'erano molte ragioni per questo: la sua salute era molto peggiorata a causa dell'epilessia; con il film Soley aveva perso parecchio denaro, e il consumo di droghe da parte di Roska e Manrico era cresciuto notevolmente. Lasciò Roma e si trasferì di nuovo in Islanda. Fece altre due mostre, nel 1990 e nel 1993. Nel 1996 il Living Art Museum di Nylistasafnid la invitò a tenere una grande retrospettiva delle sue opere. Nel mese di marzo, mentre la mostra era in preparazione, Roska tenne una performance nel museo.
Due settimane dopo Roska morì.
(bibliografia: Hjalmar Sveinsson su "Donne e ragazzi casalinghi", 2001)
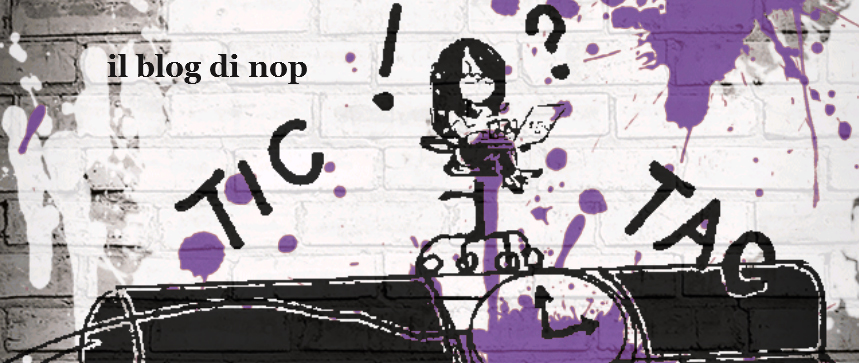





Nessun commento:
Posta un commento