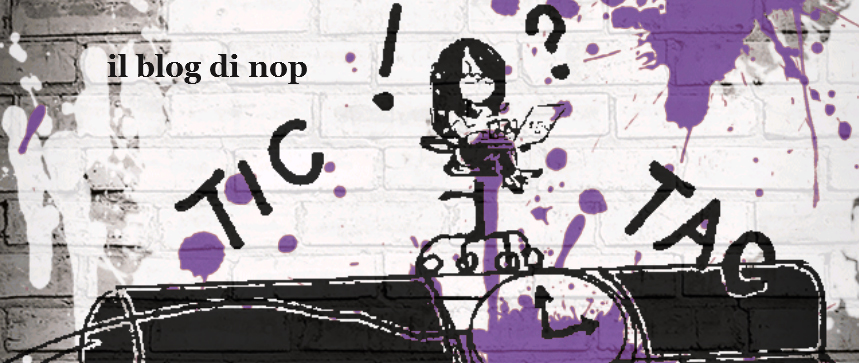Primi anni Cinquanta. Seduti sul marciapiede davanti a un bar del Greenwich Village di New York, due artisti visibilmente ubriachi, bevono dalla stessa bottiglia. Si scambiano ad alta voce complimenti del tipo: «Sei tu il più grande pittore d’America», diceva uno. «No, no sei tu il più grande pittore d’America», risponde l’altro. Il teatrino va avanti fino a quando uno dei due perde i sensi. Era Jackson Pollock . L’altro era Willem de Kooning.
Erano amici. Ma per loro la “grandezza” era un’autentica ossessione, era la lotta per trovare un posto di rilievo sul mercato, per chi riusciva a spingersi più in là nella sperimentazione artistica. Così, benché si stimassero e nutrissero sentimenti di affetto, erano “rivali”. Successe che Pollock, rispetto all’immigrato De Kooning, venne usato dal potere come prova del vero talento americano rispetto ai geni soffocati dalla censura del blocco sovietico; successe che De Kooning – che non riusciva a trovare una netta separazione tra linguaggio astratto e figurativo - fosse geloso del fatto che Pollock era diventato famoso facendo sgocciolare dal pennello che muoveva in aria disegnando nello spazio vuoto la vernice sulla tela appoggiata sul pavimento. Pollock lo derideva e De Kooning soffriva. Alla fine, quando nel 1956 Jackson guidando ubriaco perse il controllo della sua Oldsmobile, si schiantò contro due alberi e morì sul colpo, De Kooning esclamò: «È morto. È finita. Sono io il numero uno». A meno di un anno dal funerale, De Kooning iniziò una relazione con la ragazza dell’amico-nemico, l’unica sopravvissuta a quell’incidente, e ne fece la sua compagna di vita.
Visualizzazione post con etichetta bacon. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta bacon. Mostra tutti i post
martedì 21 marzo 2017
sabato 11 marzo 2017
Follia e creatività. Nella storia dell'arte così come nella vita
 |
| Il cassetto di Alda Merini |
 |
| L'olio di Adolf Hitler |

Iscriviti a:
Commenti (Atom)